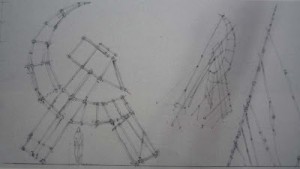Forte è la tentazione di leggere l’opera di Bernardo Bertolucci come un puntuale e, quasi didascalico, inveramento delle dinamiche inconsce della psiche, la cui classica elaborazione teorica ci è stata offerta da uno dei più grandi pensatori del Novecento, Sigmund Freud, l’inventore della psicanalisi.
Tale tentazione ermeneutica può ambire allo sdoganamento, se non addirittura ad una naturale legittimazione, quando è lo stesso regista che con grande non-chalance e disinvoltura dichiara pubblicamente che “personalmente, faccio film per motivi terapeutici (1), affermazione che, a primo acchito, parrebbe scaturire da una certa snobberia borghese velata di ironia, degna del miglior Woody Allen, ma che, ad un’attenta lettura dell’opera, si palesa come verità nuda e cruda nella sua disarmante effettività.
Per non parlare poi dell’ossessivo impiego di una terminologia da psicanalizzato immancabile nel lessico bertolucciano,‘masticata’ tanto bene da ridurre il complesso di Edipo ad una sorta di prêt-à-porter:
“Il film (Prima della rivoluzione) risulta allagato da istanze inconsce e sono stati necessari più di dieci anni di analisi perché Prima della rivoluzione diventasse La luna e la zia diventasse la madre” (2);
“Tara è anche una parola molto infantile: “Tara” è come la parola detta da un bambino che comincia a parlare; forse è il modo per dire “cara” alla madre. Non a caso questa città è nata dopo due o tre mesi che avevo iniziato l’analisi, cioè nel momento di grandissimo entusiasmo per la scoperta freudiana” (3);
“In questo senso è un film (La strategia del ragno) che ha l’iter di una terapia di tipo psicanalitico, e Tara è come l’inconscio” (4);
“Il conformista è la storia di me e Godard (…) Io sono Marcello e faccio film fascisti e voglio uccidere Godard che è un rivoluzionario, che fa film rivoluzionari e che fu il mio maestro” (5)
“In Ultimo tango a Parigi, con Jean-Pierre Léaud, “uccido” il cinéphile che sono stato” (6);
“Tanto per cambiare è un film (La tragedia di un uomo ridicolo) sul voyeurismo” (7).
Ora, ciò che rende l’approccio all’opera di Bertolucci irresistibilmente seducente è l’effetto cortocircuitante prodotto da una contraddizione derivante dall’indicazione, da parte del regista, della psicoanalisi come strumento ermeneutico privilegiato della propria opera filmica, e dalla descrizione dei fenomeni inconsci come oggetti ‘dispiegati’ consapevolmente nel testo filmico. In altre parole la visione dei film, nel contesto delle dichiarazioni dell’autore, fa nascere nello spettatore accorto il presentimento, se non la convinzione, che il regista sia colto da megalomania nel momento in cui investe se stesso di un duplice ruolo, quello dello psicanalista e quello del paziente, espungendo definitivamente l’Altro come termine imprescindibile di confronto… Tanto che un ulteriore, aberrante quanto spregiudicato delitto nevrotico, sembra si debba inevitabilmente aggiungere alla lista, ovvero l’ ‘uccisione’ del sommo padre Sigmund Freud, coronamento di una serie di ‘delitti’ per cui Bertolucci si era già ‘costituito’: il padre naturale Attilio, i padri del cinema Pasolini, Godard e Bresson…
Lo spodestamento del padre Freud ha avuto come inevitabile conseguenza lo sguinzagliamento del novello Prometeo errante per l’empireo dell’inconscio, attraverso quegli spazi mitici, senza confini ed orizzonte che il nostro regista ha riconosciuto nel deserto marocchino de Il the nel deserto, nell’Asia de L’Ultimo Imperatore e, naturalmente, nella Bassa Padana di Novecento:
“In Novecento avevo bisogno di un microcosmo che in qualche modo però fosse anche assoluto e quindi diventasse un macrocosmo. La Bassa, se ci stai dentro, non ha confini, non vedi monti, tranne in rarissime giornate estremamente limpide dopo piogge eccezionali, ma in generale la Bassa non ha confini, quindi è un mondo come in espansione, la Bassa è come un fotogramma di pellicola, il fotogramma di un film che non si chiude sopra, in basso, a destra o a sinistra, è un quadro senza cornice, una tela senza la cornice voglio dire (…) non esistono punti di riferimento, se non filari di pioppi (…) se non cime di campanili, voglio dire che la Bassa è quello che volevo io, un microcosmo che desse la sensazione di un universo” (8).
Di quegli spazi e delle sue strutture il nostro Prometeo della celluloide si è dichiarato re e demiurgo ma, la sfida è lanciata, il suo destino è segnato e il ragno, per citare Bertolucci, si ritroverà imprigionato nella stessa ragnatela che ha tessuto.
25 aprile 1945: un atto mancato
Campo della suddetta tenzone sarà il film Novecento, partorito in un momento particolarmente favorevole a Bertolucci, reduce dal successo planetario di Ultimo Tango a Parigi e con a disposizione una valanga di soldi americani per finanziare (a suo dire) un film “rosso”, insomma l’occasione perfetta per scatenare l’ego dell’ enfant maudit. A questo proposito è lo stesso Bertolucci che descrive il proprio stato d’animo in quel momento:
“Ci sono film destinati a materializzare le fantasie infantili di onnipotenza del regista, che hanno tempi di ripresa tanto lunghi da essere paradossali, e di conseguenza problemi di montaggio quasi insolubili a causa della mole di materiale girato” (9).
“Dopo Ultimo tango, potevo fare tutto quello che volevo e mi sono quindi detto: “Farò una sorta di film-ponte tra il cinema hollywoodiano e sovietico, tra la finzione hollywoodiana e il realismo socialista”. Tutto questo mi eccitava enormemente e il film è il risultato di un momento in cui, non mi vergogno a dirlo, ero un po’ megalomane. Volevo fare il film più lungo…” (10).
Ebbene, in questa sede ci piacerebbe dimostrare, con un certo gusto per la provocazione che vogliamo mutuare proprio da Bertolucci, che “le fantasie di onnipotenza” dell’autore nel film sono asservite (in forma inconscia?) esattamente ad un esito a loro contrario, distruttivo; la “megalomania” è foriera di un atto mancato, nell’accezione psicanalitica della vicenda edipica e quindi della reale impossibilità di uccidere il padre, che si condensa nel giorno della Liberazione, il 25 aprile 1945.
Novecento è un film che presenta una fantasmagoria di figure paterne nelle diverse declinazioni del padrone, del patriarca, di una non meglio precisata auctoritas… Non a caso la scelta dei volti dei patriarchi era caduta su due carismatiche icone del cinema hollywoodiano come Burt Lancaster e Sterling Hayden che contribuivano, con la loro notorietà, a proiettare il film in una dimensione mitica.
Con ciascuna di queste figure paterne il regista intrattiene un rapporto conflittuale, violento seppure in forme non sempre facilmente codificabili.
È lo stesso regista che ci mette all’erta sui sentimenti “spuri” che nutre nei confronti della famiglia dei Berlinghieri, i possidenti terrieri:
“Nel parlare della famiglia dei padroni pensavo ad una sorta di condanna morale che avrebbe potuto scaturire nel racconto da una sottile strategia introspettiva, quasi un filtro proustiano. È balzato incoercibile, in primo piano, invece, qualcosa di spurio, pieno di violenza, di spietatezza verso questa famiglia di possidenti. Pensavo che avrei potuto guardare alla realtà sociale dei Berlinghieri attraverso una fascinazione della memoria, senonché ho dovuto fare i conti con l’altro polo dialettico della vicenda, il radicale contrasto di classe con la famiglia proletaria dei Dalcò” (11).
Nel corso della scrittura della sceneggiatura, l’idea di una solipsistica autocondanna morale dei padroni perde piede in quanto la classe dei padroni diviene uno dei poli dinamici di un conflitto che vede come antagonista la famiglia dei Dalcò, i proletari. E’ a questo punto che il piano della storia si intreccia, inscindibilmente, con le istanze personali del regista: il contrasto padrone-proletario attualizza il conflitto padre-figlio secondo le dinamiche proprie del complesso di Edipo. Solo così si può spiegare l’emersione “incoercibile” (perché inconscia), in fase di elaborazione della sceneggiatura, della violenza e spietatezza verso i Berlinghieri.
Tuttavia gli atteggiamenti ostili o traumatici nei confronti della figura padre-padrone sono destinati, come vedremo, a riaffermare puntualmente la sostanziale inviolabilità della medesima: il disperato tentativo di scalzarla o annientarla è sempre votato all’insuccesso in quanto, secondo le dinamiche pulsionali che governano il complesso edipico, il desiderio di morte che nutre il bambino nei confronti del padre è sempre frustrato.
E la riprova di quanto detto viene proprio dallo stesso regista che affibbia al fascista Attila il nome del padre naturale Attilio… In verità, come ci premureremo di dimostrare più avanti, Attila è una delle poche figure maschili che non assurge a ruolo di padre. Perciò la condanna e l’esecuzione capitale del fascista Attila non coincide con l’uccisione dell’‘istanza padre’ ma Bertolucci opera, inconsciamente, un’ingannevole traslazione di valore da una figura all’altra.
Sebbene, come si vedrà, l’irrefrenabile desiderio di morte del padre-padrone si appunta in primis sulla famiglia dei Berlinghieri, è però anche vero che assistiamo in Novecento ad almeno un’occasione in cui l’attualizzazione del complesso di Edipo si rende evidente presso la famiglia dei Dalcò, con esiti però di natura opposta: è l’unica volta in cui il rapporto tra proletario e padrone si ribalta a vantaggio del primo in quanto si costituisce il rapporto padrone-figlio versus proletariato-padre. Si tratta della sequenza in cui Leo Dalcò chiama a sé il nipote in una sorta di cerimonia di investitura dei valori del socialismo.
La scena è girata in una calda luce aranciata attorno alla tavola, luogo, per antonomasia, della comunione del cibo e dei valori di fratellanza. La scena, come testimonia Vittorio Storaro, direttore della fotografia di Novecento, intrattiene un rapporto d’elezione con un dipinto del pittore naïf Gino Covili intitolato Discussione per la formazione della Cooperativa (12) ove i paesani emiliani sono raccolti intorno alla tavola con le mani grandi e i corpi robusti di contadini.
Nel film Olmo viene fatto salire sulla tavola e, tra cibi e vivande, si avvicina al nonno sovrastando tutti quanti nella sua missione di depositario dei valori del proletariato e quindi di degno sostituto del patriarca Dalcò. Tuttavia Olmo, in questo frangente, è portatore di un valore opposto, quello della proprietà privata in quanto vuole trattenere per sé la moneta guadagnata per la pesca delle rane: “Il soldo è mio!”. Ma la sua posizione spaziale ‘prevaricante’ nei confronti del padre-nonno è subito negata dall’imposizione di quest’ultimo di cedere all’intera comunità la moneta. Così, per la prima e unica volta nel film, si compie la rivoluzione comunista nell’alveo dell’educazione familiare: la vittoria dei valori della “comunanza” sui valori della proprietà privata.
Il 25 aprile, dice Bertolucci, “è un giorno che include l’intero secolo. Lo abbiamo preso come una sorta di giorno simbolico sul quale è sguinzagliata, sul quale fiorisce questa utopia contadina; e questo giorno include tutti i fatti condizionanti, tutti i fatti necessari” (13).
Il 25 aprile è il giorno della resa dei conti del conflitto che ha visto opporsi, nel film, per mezzo secolo padroni e schiavi, la borghesia agraria e il proletariato. Ma in fin dei conti ciò che si vede sullo schermo è lo scacco del proletariato, dei contadini, dei poveri e degli asserviti, degli stessi partigiani che consegnano le armi alle milizie mentre il padrone restaura il proprio dominio dopo aver subito un improbabile processo popolare, che ha il sapore più di una farsa che di una rivalsa.
E la proposta di Bertolucci di far passare tale disfatta per “utopia contadina” non è convincente poiché un aquilone rosso sventagliato da una parte all’altra di un’aia (con le parole di Bertolucci: “la più grande bandiera rossa mai vista al cinema, ricavata dall’unione di tutte le bandiere rosse che i contadini avevano nascosto durante il fascismo” (14)), seppur non scevro di un certo lirismo, non ha lo spessore e la complessità progettuale di un’utopia. Stesso stucchevole impatto hanno le sequenze preliminari allo sfoderamento dell’immensa bandiera rossa, con l’abbraccio dei proletari della montagna e della pianura, uniti per far trionfare il comunismo: “Hei compagni, è vero che date la terra a chi la lavora?”. Molta parte della critica in effetti si impennò contro lo schematismo ideologico che ravvisava nella sequenza del 25 aprile, condannando la ripresa di un’iconografia, di un’arte di propaganda che si rifaceva alle “peggiori convenzioni del cinema realista-socialista di propaganda così com’era concepito e praticato in URSS nell’epoca staliniana” (15). Un altro esempio di enfatica espressione ideologica è rappresentato dai bozzetti di Ezio Frigerio per il ‘monumento’ al comunismo riproducente la falce e il martello e quindi di nuovo un’iconografia facile, ridondante che non trattiene pressoché nulla delle sperimentazioni fresche e innovative degli ideali avanguardistici del giovane Tatlin, per esempio.
Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Concluderemo la rassegna con l’ennesimo ‘manifesto’ comunista di cui si fa mentore Olmo il quale, per la prima volta nel film, guarda in macchina andando a cercare gli occhi dello spettatore ‘simulando’ ingenuamente un appello propagandistico… Il carattere retorico del discorso si esaspera ancora di più se pensiamo che la scena rimanda al dipinto di Giuseppe Pelizza da Volpedo, Il Quarto Stato, che fa da sfondo ai titoli di testa del film: ad Olmo spetta il primo e primissimo piano mentre il resto delle comparse costituiscono lo sfondo, la folla, la fiumana dei paesani che invocano giustizia senza farsene davvero i promotori.
Allora, quale è in sostanza l’utopia di Bertolucci? È inesistente. Il processo popolare è finalizzato alla condanna del padrone e non ad un’edificante impalcatura utopica volta alla costituzione di una società diversa…
A meno che si voglia identificare tale utopia con le parole che il vecchio Leo morente rivolge al nipotino Olmo in Atto I: “Sarà questo il socialismo? I ricchi tutti lì a sudare e noi poveri qui sotto un albero a pancia all’aria? È troppo bello per durare”. Ma anche questa è una farsa, un sovvertimento carnascialesco dei rapporti di forza tra padrone e servitore che però è destinato a ristabilire lo statu quo e che richiama, come ha acutamente osservato T.J. Kline, il teatro di stalla, “un genere spontaneo di dramma contadino” in cui “i contadini recitano una commedia in cui l’ordine tradizionale dei ruoli è invertito: l’esempio più ricorrente è il padrone che diventa servitore” (16).
L’impressione è che il desiderio, la pulsione irrefrenabile di rivalsa si consumi tutta in questa galleria di manifesti estetizzanti ma, di fatto, poco efficaci e nel trionfo della musica popolare. Novecento è, infatti, un grande affresco popolare che si richiama al teatro musicale ottocentesco.
La musica è la grande onda che raccoglie le speranze e le delusioni dei contadini e dei proletari e che ne mitizza il cammino storico. Si pensi appunto alla sequenza del 25 aprile in cui il processo al padrone si risolve in una festa popolare o all’esecuzione di Attila rispetto alla quale Tullio Kezich osservava che essa “avviene a suon di musica come in una scampagnata ritualistica: non sembra che i contadini vadano ad uccidere un uomo ma a “segare la vecchia” (17)”. O ancora si ricordi la vicenda del Montanaro che, alla richiesta di altro cibo da parte dei propri figli, risponde: “te la faccio passare io la fame” e incomincia a suonare un piccolo flauto. La musica consola, la musica imprime uno scatto di inebriamento euforico che esorcizza, riscatta una realtà altrimenti amara. Come affermava Robert Bresson nelle sue Notes, seppure con intenti diversi, “la musica è un potente modificatore e persino distruttore del reale, come l’alcol e la droga” (18).
Durante un confronto con Pajetta, il quale riteneva la sequenza finale del 25 aprile “brutta perché storicamente falsa” (19), Bertolucci dichiarò che “nel film il 25 aprile era un tuffo nel futuro e non una ricostruzione storica del passato; non la messa in scena di ciò che era successo ma di ciò che avrebbe potuto succedere” (20).
A nostro modo di vedere qui Bertolucci è vittima di uno ‘scivolamento’: l’espressione “tuffo nel futuro” non s’addice all’utopia che egli pretestuosamente crede di aver fondato, bensì ad un meccanismo tutto inconscio per cui il desiderio di rivalsa dello schiavo-contadino, ovvero del figlio, sul padrone-borghese, ovvero sul padre nella vicenda del complesso di Edipo, è destinato a venir sempre frustrato nella realtà del presente (il desiderio di uccidere il padre da parte del figlio rimane frustrato poiché represso) ma pur tuttavia rigenerato all’infinito (nell’immediato futuro prossimo) in quella che, in termini psicanalitici, è definita compulsione a ripetere.
Tant’è che tale desiderio di morte del padre-padrone, frustrato nella sequenza del 25 aprile, si avvera (ma solo in parte) nella scena finale, al secondo tentativo!
Il film, come si ricorderà, termina con una scena dal sapore ancora una volta comico-farsesco in cui i due protagonisti si azzuffano (inscenando la lotta di classe) per poi morire come i loro antenati, l’uno di vecchiaia adagiato su un palo, l’altro di morte violenta, attraverso il suicidio.
Siamo convinti che questa scena non risponda semplicemente ad una volontà di coerenza formale ma ad una vera e propria necessità di “Liberazione”, di compulsione a ripetere un atto dettato da un desiderio sempre frustrato.
Il suicidio è la formula perfetta che nel film “sublima” questo desiderio frustrato di onnipotenza: il figlio-regista uccide effettivamente il padre ma, poiché tale desiderio è represso dai sensi di colpa, nasconde la mano e ‘inscena’ un suicidio…
Tale dinamica, in realtà, l’avevamo già incontrata nella scena del suicidio di Alfredo Berlinghieri senior.
L’autocondanna morale del padrone che, nelle intenzioni del regista, “avrebbe potuto scaturire nel racconto da una sottile strategia introspettiva” in realtà non ha luogo.
Se si dovessero ricercare le ragioni di tale atto nelle parole di Berlinghieri, si arriverebbe alla conclusione che egli decide di togliersi la vita perché ormai vecchio e impotente: “I giovani ballano, si abbracciano e prima di sera fanno l’amore”, “Questa non è terra per vecchi”, “La dannazione è dentro di noi. La maledizione peggiore sai qual è? (…) E’ quando non ti tira”.
Tali ragioni sono tradite da quanto sostiene Leo quando scopre il cadavere: “Ah, se poteste vedervi, signor Alfredo, non siete mica morto da padrone! Ma che bisogno c’era di slegare tutte le vacche! Per farmi lavorare di più? Forse la verità è che quando un uomo non fa niente per tutta la vita, ha troppo tempo per pensare e, a forza di pensare, diventa rimbambito”.
Le ragioni di Dalcò tradiscono quelle di Berlinghieri. Alfredo, in realtà, è morto da padrone: si è tolto la vita perché ha riconosciuto la propria impotenza e ha slegato le vacche perché con quelle catene si è impiccato…
Dalcò giunge addirittura ad insinuare una sorta di dramma esistenziale. Forse un’autocondanna? In realtà egli si fa portavoce non tanto della coscienza del padrone ma dei desideri di rivalsa del proletariato, travisando la realtà.
Ciò viene dichiarato esplicitamente nella scena successiva ove viene redatto il falso testamento di Alfredo senior in una scena fortemente suggestiva per la predominanza dei toni scuri e di una luce fioca, teatrale, debitrice della migliore pittura romantica ottocentesca italiana.
Ora, i desideri di rivalsa del proletariato si esprimono proprio secondo le modalità inconsce dello spostamento, della condensazione e della sublimazione: le ragioni dell’atto suicida vengono inconsciamente travisate, la morte del padrone è accolta, involontariamente, come una festa (tanto che ci scappa il brindisi), l’impatto emozionale dovuto all’evento viene condensato nel violentissimo sfondamento di un cocomero, una scena da infarto che, non a caso, viene fatta coincidere esattamente con la morte del padrone, annunciata da Irma: “Il padrone è morto!”.
E posto che il cocomero, in qualche modo, funga da sostituto del corpo di Berlinghieri, non è privo di significato che l’autore dell’atto sia proprio Leo che, una volta ‘sventratolo’, con la mano lo penetra strappandone le ‘viscere’ e che addirittura continua a mangiarne anche dopo essere entrato nella stalla e aver scorto il corpo appeso del padrone… Egli continua imperterrito nel suo lavoro, preoccupato che le vacche non fuggano dalla stalla in una scena che raggiunge esiti vicini alla farsa che, nella sua funzione di sovvertimento della realtà, in qualche modo ne esorcizza la portata devastante.
La visione diplopica: il mito e la storia.
Ma procediamo per gradi e, come vorrebbe ogni trattazione ordinata, partiamo dall’inizio del film, se non fosse che anche in questo caso non possiamo venir esauditi in quanto Bertolucci ha concepito entrambi gli atti di cui si compone il film come un amplissimo flash-back della durata di quasi mezzo secolo nella ‘realtà’ della storia narrata e di quasi quattro ore nell’opera filmica.
Questa particolare distribuzione dei blocchi narrativi è singolare nell’economia di un genere cinematografico quale è il mélo cui si può con facilità far assurgere Novecento per le vicende dense di risvolti sentimentali, le scene commoventi e l’uso particolare della musica, tesa ad amplificare la risonanza emotiva delle vicende narrate. C’è da chiedersi il motivo per cui Bertolucci abbia optato per il flash-back invece che far procedere la storia narrata in maniera cronologicamente lineare e optare quindi per un climax ascendente culminante nell’azione drammatica finale.
Ebbene tale scelta ha una grande importanza all’interno del discorso che portiamo avanti in queste pagine.
Infatti le prime scene del film, quelle che anticipano il flash-back, sono il manifesto del film stesso, ovvero la traduzione letterale (conscia o inconscia?) del complesso di Edipo. E il flash-back lunghissimo che segue è il tentativo di dipanare, di sciogliere i moventi, le “condensazioni” implicate nelle suddette scene.
In questo senso il film pare davvero rivestire una funzione terapeutica e dunque è giocoforza che la forma adottata per la propria espressione sia il melodramma che viene comunemente sfruttato anche come forma di psicanalisi di gruppo, per teatralizzare le dinamiche familiari così da tentare di superare, attraverso la finzione scenica, problemi determinati da ciò che viene inconsciamente rimosso.
Ma veniamo ora all’analisi delle prime scene, di quello che potremmo definire un antefatto, non nel senso tradizionale del termine, infatti tali avvenimenti si collocano cronologicamente dopo i fatti narrati nel flash-back, ma in senso genealogico: prima di tutto il motore della storia è un conflitto di forze interiori irrisolto…
La prima scena del film si apre, in campo lungo, su un gregge al pascolo che dà il “la” ad una serie di inquadrature della campagna lavorata dai contadini e dalle bestie che si ispirano alla pittura dell’ultimo ventennio dell’Ottocento, ed in particolare al Segantini de La raccolta delle patate (1890), per esempio, dove la terra, lavorata dai movimenti euritmici delle donne, si perde all’orizzonte avverando quell’effetto di “cosmo in espansione” tanto ricercato dal regista.
Il campo è attraversato da un uomo che incede al ritmo di un canto partigiano. Una volta inoltratosi nella boscaglia, viene sorpreso da un fascista che gli spara una mitragliata di colpi ferendolo a morte. A questo punto partigiani e contadini, per ‘legittima difesa’, si armano di fucili per scovare e contrastare, a guerra ormai conclusa, l’ultimo baluardo nemico. Questo avvenimento, tuttavia, costituisce un pretesto per consumare una vendetta tutta personale, ovvero quella di Leonida-Edipo che prega il partigiano Tigre di consegnargli un fucile poiché anche lui, coi propri mezzi, ha partecipato alla lotta.
Questo è un momento cruciale del film poiché è da qui che si dipartono i due livelli del discorso, il piano della storia per così dire ufficiale e il piano delle istanze personali del regista.
A riprova di quanto detto ci sono le parole di Bertolucci:
“Se torno indietro e rileggo il diario di lavorazione di Novecento, mi accorgo che a un certo punto ho contratto la diplopia…vale a dire che vedevo doppio. Più mi sforzavo a concentrarmi, più vedevo doppio. Precisamente eravamo al nono mese delle riprese” (21).
Una volta consegnato il fucile, Leonida si diparte nettamente dal gruppo di partigiani, il che è sottolineato dalla sorpresa di Tigre che è a capo del gruppetto: “Ma dove vai, Leonida?” e dalla traiettoria disegnata dal cammino del ragazzo, diametralmente opposta a quella degli altri uomini: mentre essi si dirigono verso il fuoco nemico, Leonida-Edipo, dichiarando apertamente i propri intenti: “Voglio uccidere anch’io!”, va incontro ad un destino mitico che lo conduce verso la casa del padre-padrone.
La sequenza che segue è una delle più belle del film per la perfetta compenetrazione delle due istanze di cui dicevamo; perciò si tenterà di farne una lettura doppia, sperimentando una visione diplopica…
Leonida, prima di entrare nella casa padronale, si preoccupa di pulire le scarpe infangate sullo zerbino. Questa azione si può leggere sia come un automatismo, frutto dell’educazione del ragazzo, ma anche come segno di reverenza nei confronti dei luoghi in cui regna la presenza del padre-padrone.
Leonida dunque si intrufola nella casa avvolta in un silenzio interrotto solo dal rintocco di un orologio. Gli ambienti sono poco illuminati, mutuando il sentimento di uno spazio privato, intimo, interiore come quello in cui si consuma il desiderio di morte di Edipo.
Prosegue il suo cammino diretto verso l’ascolto della radiocronaca della liberazione delle città italiane dal dominio nazi-fascista: è lì che si trova il padre-padrone.
Prima di dirigersi lì, però, spilluzzica del formaggio posato su di un vassoio, il che non si addice certo all’azione che di lì a poco verrà compiuta. Questo dettaglio mette in evidenza lo stato di incoscienza di un ragazzino-soldato, cresciuto troppo in fretta, che si sta apprestando a compiere un’azione al di sopra delle sue possibilità e, contemporaneamente, dello stesso Edipo che uccide il padre senza esserne consapevole; di qui la traduzione psicanalitica della vicenda per cui il desiderio della morte del padre è inconscio, represso.
Una volta giunto a destinazione Leonida si para davanti al padre-padrone col suo “fucilone” e gli intima di abdicare ai propri valori proclamando “Viva Stalin!”; in altri termini propone di sostituirsi al padre attraverso i nuovi ideali di cui è portatore, ovvero il comunismo ma, manco a dirlo, l’atto è mancato perché il puntuale intervento della domestica fa sì che i colpi vengano deviati dal vero obiettivo su di un dipinto appeso alla parete (22) .
Il ruolo della domestica in questa sequenza è molto importante in quanto, oltre ad avere una funzione strumentale nel dirottamento dei colpi di fucile, essa crea un rapporto caldo, familiare nella vicenda dei tre. Dal punto di vista della diegesi è chiaro che ella conosce Leonida perché della stessa estrazione sociale; tuttavia la non totale estraneità di Leonida rispetto al luogo in cui si trova, mutuata proprio dall’affettuosità della donna, favorisce un accostamento del ragazzo al padrone nel senso di una maggiore familiarità e quindi di un nesso padre-figlio più stretto…
Come dicevamo più sopra la figura del padre è inviolabile: egli non batte ciglio quando sorprende il ragazzo che imbraccia il fucile, anzi lo schernisce e si prende gioco di lui come si evince in misura ancora maggiore nel confronto tra i due nella stalla ove l’impotenza del ragazzo è riaffermata proprio in virtù della volontà del padre-padrone di assecondare amabilmente la smania di potere di un innocuo pischello. La sequenza termina con Leonida che imbraccia di nuovo il fucile contro il padrone in atto di sparargli e pronuncia la sentenza di morte: “Non ci sono più padroni!”. Non è un caso che la scena seguente, che dà inizio al vertiginoso flash-back, abbia inizio con l’annuncio di una morte (quella di Giuseppe Verdi). Lo si potrebbe interpretare facilmente come un esempio di inconscia traslazione del desiderio di morte dalla figura del padrone Berlinghieri (che nella realtà dei fatti viene risparmiato) a quella di Giuseppe Verdi: viene così soddisfatto il desiderio di morte per interposta persona, anzi sostituendo il padre dell’Opera italiana con il padre-padrone… Solo così si spiega l’annuncio della morte del grande compositore italiano ad opera di Rigoletto, che non solo è ubriaco ma addirittura rutta mentre pronuncia il nome di Verdi. Si rasenta la blasfemia! O meglio, la scena assume nuovamente, come in altre occasioni, i tratti della farsa che, come tutte le pratiche carnascialesche, ha una funzione catartica di liberazione delle pulsioni emozionali-libidiche.
Facciamo un passo indietro. La scena precedente a questa si comporta come controcanto rispetto alla prima poiché qui assistiamo ad una scena di linciaggio ‘riuscita’, operata dalle contadine nei confronti della coppia Attila-Regina.
Ci troviamo dunque di fronte allo stesso meccanismo che abbiamo incontrato nelle due scene finali del film, quella del 25 aprile e la seguente con la zuffa e la morte dei due amici ormai vecchi…
Le istanze pulsionali, frustrate nella scena che vede Leonida mancare il bersaglio, si rinnovano con efferata violenza contro i due fascisti ma, ineluttabilmente, il bersaglio (a discapito di quanto vuol far intendere Bertolucci riguardo al ‘patronimico’ del fascista) viene mancato, in quanto Attila non si può identificare con l’ ‘istanza padre’, che costituisce uno dei fulcri del complesso edipico. Ci apprestiamo a spiegarne il motivo.
Attila, l’anti-Edipo.
Attila incarna, nel film di Bertolucci, il fascismo. Attila è innanzitutto una creatura famelica, un mostro di violenza, un carnefice. Sono diverse le scene in cui questo aspetto emerge in maniera sintetica e, perciò, straordinariamente intensa.
Basti pensare alla scena agghiacciante in cui sventra, con una testata, un gattino che a suo dire è affetto dal sentimentalismo comunista. Lo vediamo prendere la rincorsa e scaricare tutta la sua energia di cane rabbioso sulla creatura innocente mentre all’esterno, nella piazza attigua al covo di fascisti, si celebrano i funerali dei quattro anziani della Casa del Popolo con un ritmo lento, dimesso ove il corteo degli uomini è ripreso con uno stile registico che rimanda al genere documentaristico.
Per ben due volte, nella soffitta assieme a Regina e prima di essere giustiziato, egli si definisce un cane da guardia e una bestia tanto che inizia a grugnire come un porco.
Il truce omicidio di Fabrizio, la cui testa viene fracassata da Attila attraverso un movimento rotatorio centrifugo, è l’ennesimo episodio che segna l’escalation di atrocità compiute dalla coppia di mostri. La scena indugia anche sulla sessualità perversa dei due fascisti che stuprano il bambino e lo costringono ad assistere al loro coito. Le tendenze sadomasochiste dei due sono poi riaffermate più oltre nelle parole che Attila rivolge a Regina: “Gli insulti, le umiliazioni mi danno forza”. Il rapporto tra sessualità e politica, tra perversione sessuale e nazi-fascismo pare una costante della letteratura e del cinema della seconda metà degli anni Settanta e inizi Ottanta. Basti pensare al Pasolini di Salò o al Portiere di notte di Liliana Cavani… Naturalmente è opportuno sottolinearne gli esiti diversi: se in Salò la perversione sessuale diventa la cifra dell’impotenza del potere, nel film della Cavani finisce per costituire una riflessione sulla natura profonda delle pulsioni umane e sul sadomasochismo che le governa. In Novecento la perversione sessuale mutua un significato ancora diverso: denucia la sessualità immatura, infantile di Attila e Regina, la quale, fin dai primi esperimenti sessuali con il cugino Alfredo, manifesta l’incapacità di vivere la sessualità in maniera completa, appagante: ella ne costruisce un surrogato fatto di travestimenti e feticismo.
Una terza scena, l’omicidio della signora Pioppi, ripete esattamente il topos della furia fascista che abbiamo riscontrato nelle scene precedenti: Attila prende la rincorsa e sfonda la porta del salotto.
Degna di nota e, a nostro avviso, geniale soluzione registica è l’identificazione della furia fascista con un movimento al quale si imprime un’accelerazione e che, nella propria crescita esponenziale, diviene incontrollabile. Attila è un distruttore in virtù di una forza che supera la sua volontà. Si ricordi la scena dell’omicidio di Fabrizio e, in particolare, lo stato di trance in cui si trova Attila quando l’atroce giostra della morte, di cui egli è il motore, si arresta…
L’accecamento della ragione si riflette anche nell’inverno tetro ove si compie il macabro rituale. Il paesaggio di rami secchi avvolti nella nebbia riporta alla mente Abbazia in un querceto (1809) (Fig. 5) di Caspar David Friedrich ove il sentimento del sublime si tinge di toni cupi, di un’aurea spettrale, presagio degli orrori futuri.
Il male, di cui Attila si fa promotore, assume una propria autonomia: trionfano il male per il male, la violenza per la violenza senza che vi si possa porre rimedio. Il fascismo è evocato come fenomeno dilagante, come un’epidemia. La violenza fascista assume i connotati di una catastrofe nell’accezione che ne dà Baudrillard:
La crisi è sempre questione di causalità, di squilibrio di cause ed effetti, e trova o meno la sua soluzione in un riaggiustamento delle cause. Per quanto riguarda la catastrofe, invece, sono le cause che si cancellano e diventano illeggibili lasciando il posto a un’intensificazione dei processi nel vuoto. Quello che non ha più della crisi, bensì della catastrofe, è quando il sistema si oltrepassa da sé, quando ha superato i propri fini e dunque non è possibile trovargli alcun rimedio (23).
Attila sembra uscito dal manifesto futurista di Marinetti: egli glorifica la guerra, inneggia al progresso tecnico, esalta “il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno”.
L’orrore della follia fascista si materializza nella scena della rappresaglia condotta da Attila contro i contadini che gli hanno lanciato “merda”.
Egli spara indifferentemente sugli uni o gli altri o, meglio, è sufficiente asserire che il fascismo non esiste o fischiettare l’Internazionale per morire: il confronto, la dialettica, i termini esplicativi del discorso vengono aboliti in favore di una violenza gratuita, indiscriminata: è la dittatura, la “rivoluzione fascista”!
Ma allora “chi sei tu?”, chiede Regina ad Attila. Attila è un anti-Edipo (nell’accezione psicanalitica), ne è l’antagonista. Come Edipo ha i suoi sogni di onnipotenza; come Edipo, desidera ardentemente sostituirsi al padre-padrone; come Edipo, tale tentativo di prevaricazione è votato all’insuccesso.
Per quanto riguarda il primo termine ci si riferisce alla condizione di onnipotenza del bambino che ancora non ha formato una propria identità, la quale si acquisisce solo nel riconoscimento consapevole dell’Altro.
Attila, infatti, è un Narciso che alla bellezza ha sostituito la forza machista.
Prestiamo attenzione alle sue stesse parole mentre fissa la propria figura nello specchio della sartoria ove si sta confezionando la camicia nera: “Mai avere rimpianti, mai paura. Se c’è d’aver paura di una cosa, è solo di se stessi”; quindi: “Non voglio essere elegante io, voglio essere forte!”.
Di lì a poco assisteremo alla performance che lo vedrà impavidamente lanciarsi nella sua stessa immagine allo specchio, proprio come un novello Narciso!
Come si diceva più sopra Attila aspira, come Edipo, a sostituirsi al padre-padrone attraverso una strategia dell’attesa e della sottomissione: pian piano egli si insinua nelle maglie del potere (“Non devi mai mordere la mano che ti nutre finché hai bisogno di nutrimento”). Attila proclama la volontà di sostituzione al padre-padrone in nome della rivoluzione fascista: “Tu, Alfredo Berlinghieri, e tutti gli altri parassiti pagherete il vostro conto per la rivoluzione fascista e ce lo pagherete molto salato, tutti dovranno pagare”. In realtà i propositi sono traditi in quanto egli aspira ad annientare il padre-padrone non nel nome di una rivoluzione ma dell’emulazione, come Edipo che desidera sostituirsi al padre per godere dei suoi privilegi restaurando, in definitiva, lo statu quo. Ciò si evince dalle fantasticherie cui si abbandonano Attila e Regina nella soffitta ove sono reclusi: “Ho diritto ad una casa tutta per me, una casa da vera signora!”, “Te l’immagini: noi due lì, in salotto, in due belle vestaglie di seta, ad ascoltare una trasmissione radiofonica; un servo in livrea entra e ci porta due bicchierini di marsala all’uovo” e quindi: “Marsala i miei coglioni! Io voglio champagne!”
Tale immagine si materializzerà poco tempo dopo nella cucina di villa Pioppi, di cui i due si sono impadroniti in maniera illecita.
Assistiamo ad una vera e propria doppiatura del padre-padrone da parte di Attila nella sequenza in cui questi inneggia al miracolo fascista dei cavalli a vapore che soppiantano i cavalli da tiro: torna prepotentemente alla mente l’immagine dell’entusiastico Giovanni Berlinghieri a bordo dell’aratro meccanico.
Ma, come si è anticipato, il tentativo di prevaricazione del fascista Attila, ovvero l’anti-Edipo, è destinato a fallire: egli viene giustiziato dai contadini comunisti, che si pongono, nei suoi confronti, come antagonisti. È così che assistiamo magicamente, con la fine di Attila, al compimento di due destini all’interno di due prospettive differenti, quella del mito e quella della storia: la dannazione di (anti)-Edipo e la condanna del fascismo.
È singolare la scelta di Bertolucci di ‘affidare’ la cattura e il linciaggio dei fascisti in primis alle donne che, con i loro forconi, disarmano Attila conducendolo, ormai innocuo, dagli altri popolani.
D’altra parte sono proprio le donne che detengono una sorta di ‘primato’ in questa lotta al fascismo. Si pensi alla sequenza in cui Attila, neo fattore, viene irriverentemente schernito da Anita, la maestra profuga, che invita le altre donne a gettargli addosso manciate di grano affinché il “gallo del cortile” ne possa beccare.
Questa azione trova eco nel lancio della “merda” contro lo stesso Attila di cui si fa promotrice la figlia di Anita che, non a caso, porta il nome della madre. Ed è sempre lei che infliggerà il colpo di grazia ad Attila dopo l’inseguimento delle donne.
E così il cerchio si chiude: le donne si identificano nella figura di Anita che, a sua volta, è il simbolo del comunismo militante e, quindi, della lotta contro il fascismo.
In virtù di quanto detto sopra possiamo concludere che Attila non si può identificare nell’istanza-padre, bensì è uno specchio al negativo di Edipo e perciò, non godendo dell’ ‘immunità’ paterna, si può ‘legittimamente’ giustiziare.
Si potrà osservare, a questo punto, che fino ad ora non è ancora stata contemplata la figura della donna-madre, che rappresenta il terzo ed imprescindibile polo della configurazione Edipo-figlio, Laio-padre, Giocasta-madre.
Come si sa la madre, nella dinamica edipica, è oggetto del desiderio inconscio del bambino e diventa la ragione per la quale egli vuole sostituirsi al padre.
Ebbene, in Novecento, le due protagoniste femminili, Ada e Anita, in due tempi diversi, vengono espunte dal film: l’una muore di parto e l’altra fugge dalla casa padronale.
Allora, a ragione di quanto è stato esposto fino ad ora, ci piacerebbe domandare a Bertolucci se la scomparsa delle due donne protagoniste non sia l’ennesima prova della ‘traduzione’ (inconscia?) del complesso di Edipo nel film: il bambino desidera uccidere il padre ma tale desiderio, rimanendo frustrato perché represso, gli impedisce di sostituirsi alla figura paterna, precludendogli perciò anche la conquista della donna-madre…
Conclusioni
Tale approccio ermeneutico all’opera di Bertolucci non vuole certo porsi come esaustivo ma è innegabile che sia ‘fruttifero’ e soprattutto consente di non annegare in quella querelle infinita esplosa all’uscita del film e preoccupata esclusivamente di difendere o condannare il film di Bertolucci in base alla verosimiglianza o meno dei fatti storici narrati e impegnata, nel bene e nel male, a farne un film politico tout-court. Da diverse parti si levarono varie voci che invitarono alla moderazione e a valutare l’opera anche sul piano più strettamente personale.
Ricordo, per esempio, la recensione ‘a caldo’ di Cesare Musatti:
“La prima domanda che mi è venuto di pormi quando ho visto il film è stata: come ha fatto un uomo giovane come Bertolucci, che appartiene alla seconda metà del secolo, a ricostruire la storia di un periodo anteriore alla sua nascita? Certo, ha avuto i documenti, ma questo non basta. In realtà il problema è mal posto, perché Novecento non è un film storico, è un film sul modo in cui Bertolucci vive il nostro passato prossimo. Bertolucci, cioè, non ha voluto fare una rievocazione storica, ma ha rivissuto per conto proprio un’epoca. Dunque non è utile andare a vedere nei particolari se le cose sono più o meno esatte” (24).
In questo senso ci invita a riflettere lo stesso regista con la seguente dichiarazione:
“Ogni cosa che accade in questo film a livello personale è relegata ad avere un significato più ampio, storico. È la storia di un popolo, dei contadini di quest’area geografica, un popolo che sviluppa la propria creatività per costruirsi una storia. Una storia nel senso marxista” (25).
Con grande acutezza T.J.Kline osserva che tale dichiarazione di intenti risulta un po’ confusa dal momento che sembra sia l’aspetto personale ad essere destinato ad avere un impatto più ampio, storico e non il contrario: “Questa inversione involontaria dei termini rivela che le istanze personali del film si sono infatti interposte tra lo spettatore e la storia che avrebbe dovuto essere mostrata” (26).
(22) T. J. Kline asserisce in I film di Bernardo Bertolucci, Gremese Editore, Roma 1994, a p. 112 che Leonida “spara accidentalmente a un ritratto del patriarca Alfredo Berlinghieri”. In realtà non ci pare che si abbia modo di scorgere tale ritratto. Comunque, se così fosse, il ritratto si comporterebbe come un feticcio della figura del padre-padrone attivando un meccanismo di traslazione delle pulsioni istintuali e quindi di spostamento del significato.